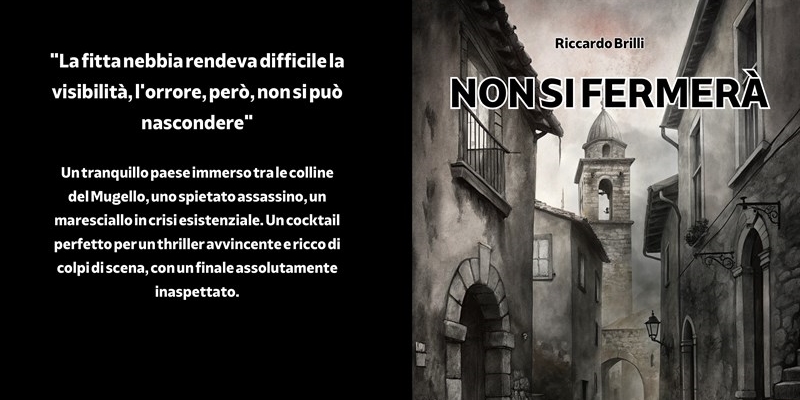Dante Alighieri © N.c.
Dante Alighieri © N.c.
Nel rievocare brevemente la travagliatissima esistenza di Dante, non si può fare a meno di sottolineare quel suo infelice potere, che egli ebbe in vita nel suscitare contro di sé tante inimicizie e odi profondi. Con una espressione molto semplice possiamo dire che era un uomo con un “disgraziato carattere”, ma anche vittima di un avverso destino. Cerchiamo di tratteggiare l'uomo e il poeta.
Immaginiamocelo, chiuso nel suo lucco rosso, mentre senza alcun riguardo faceva sentire agli interlocutori il peso della sua superiorità intellettuale. In questo modo si era comportato a Firenze al tempo del Priorato quando, discutendo su chi dovesse prendere parte ad una ambasceria aveva, con una brevissima frase, affermato di essere il solo degno e al contempo l'unico veramente indispensabile a rimanere per il bene della città. “S'io va chi resta? E s'io resto che va?. Così aveva detto e fra le tante frasi inopportune da lui pronunciate, questa fu, forse, una di quelle che più lo avevano danneggiato. Del resto, si vuole, che questo fosse il suo tono, un tono che egli mantenne per tutta la vita.
Ma a ben vedere, la Divina Commedia non è solamente la massima creazione poetica dello spirito umano, è anche l'autobiografia del suo autore, soprattutto per la verità dei sentimenti che vi sono annotati. La “Commedia” fu per lui l'opera alla quale confidò dolori e affetti, senza mai alterarli e, forse, è questa nota di straordinaria umanità che innalza il valore artistico del poema fino alle stelle. L'uomo Dante vi è dentro, integro, senza alterazioni.
Scorrendo il poema per rintracciarvi i segni della sua personalità, restiamo spesso impressionati dalla crudezza e dalla violenza dei giudizi espressi nel poema: nella “Commedia” egli rivela come fosse sublime nei momenti di esaltazione spirituale, ma anche violento e intriso di sconcertanti volgarità, nelle frequenti, intime ribellioni.
A titolo di esempio, il feroce rancore usato dal poeta per colpire Filippo Argenti: chi era costui?
Filippo Cavicciuli era soprannominato Argenti per il vezzo borioso di ferrare il cavallo con ferratura d'argento e la famiglia di Filippo apparteneva alla consorteria degli Adimari di Parte nera. Una sorda disputa fra queste due famiglie c'era già, si accentuò quando l'Argenti chiese a Dante, suo vicino di casa, di recarsi dal giudice e mettere una buona parola per salvarlo da guai giudiziari. Ma il poeta, che da tempo non vedeva di buon occhio Filippo, aggiunse, invece, capi d'accusa che fecero raddoppiare l'ammenda. Si racconta, anche, che l'Argenti abbia preso a schiaffi Dante e che la sua famiglia si oppose sempre alla revoca del bando a carico del poeta.
Dante si compiaceva anche di ripetere le più sconce parolacce per il gusto di offendere le orecchie degli schizzinosi. Ciò, non tanto per il gusto di divertire con qualche volgarità gli sboccati e i burloni, la Divina Commedia non è certo poema giocoso; c'era piuttosto la cruda affermazione della sua superiorità intellettuale e il grande disprezzo per i malvagi e la gente da poco.
Egli stesso confessava che la superbia, unitamente all'orgoglio, erano i suoi maggiori difetti. Negli anni giovanili si inorgogliva della sua discendenza da quel Cacciaguida che era stato guerriero ed era morto in Terrasanta, ma la sua famiglia in città non godeva di molta considerazione, gli veniva rinfacciato di essere figlio di un cambiavalute e uno dei bistrattori più duri pare fosse suo cognato Forese Donati e Dante si sentiva soverchiato dai suoi stessi parenti.
Altro cruccio era la povertà, anche se egli non era bisognoso nel senso stretto del termine: le case fiorentine a San Martino del Vescovo erano sue e della famiglia, unitamente ad alcuni poderi. Ma cosa rappresentavano quella poca terra e le quattro mura in confronto delle case-torri dei Donati e dei Sacchetti che gli grandeggiavano attorno, le quali rappresentavano un monito che intimava al poeta di starsene umile e cheto e Dante, che sapeva di valere come cento di loro messi assieme, si rodeva e quando capitava l'occasione, infliggeva colpi durissimi con quelle armi – la penna e la lingua – che erano più taglienti di una lama.
Ma, forse, la causa vera e più profonda dell'infelicità di Dante Alighieri non era dovuta né all'orgoglio, né alla superbia, ma all'amore che gli riempiva il petto e che mai l'abbandonò, sia da giovane, nella maturità e nell'età senile. Così, molte invettive che sembravano dettate dall'odio erano nate in realtà da un sentimento opposto. Come quelle cose che diceva e scriveva su Firenze, che nessun fiorentino forse l'amò come lui, tanto da intenerirsi quando ne parlava desiderando, più che la gloria e la ricchezza, come sostenevano i suoi detrattori, di rivedere il bel San Giovanni presso al quale aveva vissuto spensierato i giorni della sua giovinezza.
Umanamente aveva nutrito un forte sentimento per una fanciulla che da ragazzo aveva visto e che sempre aveva pensato a lei e a 18 anni, quando lo aveva gentilmente salutato si era sentito felice; e aveva sofferto atrocemente quando essa, poi, aveva riso di lui vedendolo impallidire e quasi cadere dall'emozione di averla ritrovata.
Tutti la chiamavano Bice, ma per lui era Beatrice per la beatitudine che essa li dava. Non aveva mai veramente pensato di farla sua, né mai, forse, si era domandato se ella lo amasse e non si era adombrato vedendola andare sposa ad un altro uomo; si era invece dato alla disperazione quando ella morì all'età di ventiquattro anni.
In realtà, forse, più che amore acceso per una donna, era stato un aspetto, una forma del grande amore che aveva già nel cuore, con cui era nato e che accompagnò – questo grande genio – per tutta la vita, è come se il poeta avesse colto una scintilla di eternità negli occhi di Beatrice. O se vogliamo, il suo sentimento di ardore amoroso verso di lei, costituisce esattamente l'indicazione metaforica della forza dell'amore verso Dio, alla quale il poeta aveva dato il nome e l'immagine di Beatrice, innalzandola all'altezza di un supremo ideale di perfezione e di bontà.
E dall'amore aveva tratto le su liriche più belle, ascoltando ciò che il cuore gli dettava dentro, registrando ogni suo pensiero e ogni suo sentire, in un poema nel quale non aveva voluto cantare battaglie, guerrieri o vittorie cruente, ma soltanto l'amore: “l'amore che muove il sole e l'altre stelle”.
Questo, in estrema sintesi e a mio modo di vedere, il ritratto di un uomo scontroso, di un grande genio orgoglioso e infelice, che affidò i suoi tormenti a un'opera immortale.
Alfredo Altieri